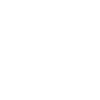
Brani
Dal capitolo II “La lezione dal passato”. Racconti di infanzia di scugnizzo.
Mio padre aveva un esercizio commerciale alla Duchesca e lì viveva da sempre la mia famiglia, molto operosa, di quella piccola borghesia che conserva valori e sentimenti con cura devota e li trasmette, di generazione in generazione, ritenendoli fondamentali per un sano nucleo familiare. Lavorava, e tanto, mio padre don Peppe, come tutti amavano chiamarlo, perché teneva molto a non far mancare nulla alla numerosa famiglia. Nemmeno il mare d’estate, prima a Coroglio e poi, quando lì diventò impraticabile a Scauri (prima solo nel mese di agosto, poi anche a luglio), dove si ritrovavano tante dignitose famiglie, seppur meno agiate di quelle che potevano permettersi le marine di Capri o di Positano.
La nostra estate, mi riferisco alla mia e a quella dei miei amici, cominciava però agli inizi di maggio: il debutto, come sempre, avveniva al lido Conchiglia di Coroglio. Passavamo ore a tuffarci da un piccolo ponte, che ancor oggi è situato a metà della strada che porta all’isolotto di San Martino; però ora quei tuffi sarebbero impossibili perché, oltre al porticciolo turistico su pontili galleggianti, hanno piantato anche un distributore di benzina per le imbarcazioni che affaccia direttamente sul mare. Quel luogo ci era così caro da non farci accorgere neppure che vicino vi fumava la ciminiera dell’alto forno dell’Italsider: il paesaggio allora era ancora idilliaco e godibile. Mio padre si concedeva due giorni a stento di vacanza l’anno, più che vacanza potrei dire di riposo: solo la vigilia e il giorno di ferragosto, quando la città si spopolava e non c’era motivo per restarvi. Arrivava a Scauri con la sua auto, la ricordo splendida, per la quale aveva una gran cura. Stare qualche giorno tutti insieme ci faceva sentire meglio. Era l’occasione per parlare, confidarsi, sorridere anche dei vezzi nostri e di chi ci frequentava. Ore indimenticabili davanti al mare e a gigantesche pizze margherita. C’era una cosa che mi piaceva, come del resto piaceva a una buona metà degli scugnizzi napoletani, al di sopra di ogni altra: tuffarmi nelle fontane pubbliche, non importava se di Napoli o di Scauri, a rischio di rompermi la testa. Non la testa mi ruppi in uno dei miei famosi tuffi, ma una mano sì, grazie al poco piacevole incontro con una bottiglia di vetro. Come al solito ero di corsa quella mattina, appena uscito dalla casa di villeggiatura, con uno stuolo di ragazzini, amici stagionali, irrequieti quanto me e insieme puntavamo dritto alla fontana che si ergeva proprio di fronte alla spiaggia, frequentata abitualmente dalla mia famiglia. La corsa a rompicollo terminò con l’immancabile, scenografico tuffo nella fontana. Di solito i villeggianti non ci facevano neanche più caso, presi com’erano a conquistarsi il fatidico posto al sole.
Quella mattina però un uomo anziano che sostava appoggiato al bordo della fontana per godersi un po’ di frescura, al mio tuffo, di cui non si era accorto per tempo, investito improvvisamente dagli spruzzi, iniziò ad inveire e gridare in romanesco. Temendo che lo schiamazzo richiamasse l’attenzione di mia madre, mi affrettai ad uscire, aggrappandomi in tutta fretta al bordo; appoggiando la mano all’estremità della vasca, però, qualcosa di tagliente mi si conficcò nel palmo, colorando quasi all’istante di rosso l’acqua. Prima ancora che potessi rendermi conto di quanto stesse accadendo, sentii le voci spaventate dei miei compagni. Seguì, quindi, la solita corsa in ospedale, questa volta scortato da un provvidenziale amico di famiglia, il quale, mentre mi mettevano i punti, non riusciva a capacitarsi del perché, con tutto quel mare a disposizione, noi preferissimo tuffarci nelle fontane. Appena mia madre lo seppe scattò il divieto di riprovarci, con l’accompagnamento di un sonoro ceffone; il divieto sarebbe stato nel tempo ovviamente disatteso. Quei tuffi nelle acque fredde nello spazio ristretto della vasca di una fontana pubblica erano un piacere indescrivibile a tal punto che, appena tornato a Napoli, presi a ripetere più volte l’esperimento, nella fontana rettangolare di Piazza Municipio, con una “corte” diversa di amici.
Ci sedevamo sul bordo, i piedi in acqua, a petto nudo come pulcini al sole, a goderci la bella e lunga estate, prima di un nuovo autunno e soprattutto di un lungo, faticoso incontro con libri e quaderni. Le mie giornate si svolgevano prevalentemente nel mio quartiere. Un nome che mi suonava importante, man mano che crescevo e mi venivano raccontate le storie di duchi e di dame vissute nelle vicinanze della bottega dove mio padre poteva in qualche modo tenerci d’occhio – o si illudeva di poterlo fare – in quelle strade dissestate fra palazzine diroccate. Infiniti i luoghi che ospitavano le nostre grida gioiose e le nostre sfrenate corse: come Piazza Mercato che, soprattutto nei giorni festivi, quando era sgombra dai banchi dei commercianti, offriva l’intero suo spazio per una delle mie passioni preferite, il calcio. Quasi tutti i miei amici avevano un soprannome, come era d’uso e lo è tuttora in quella Napoli popolare che ama fotografare un particolare, ribattezzando il personaggio proprio in base a quella peculiarità. E, se è un difetto, nessuno, proprio nessuno, mostra di offendersi, perché appartiene alla spontanea vivacità della nostra gente. Così c’era Gianni ‘o chiattone, che lo era per davvero, per i tanti chili di ciccia e di furbizia; poi uno che chiamavano ‘a mozzarella, per il colore troppo chiaro della carnagione, che anche al sole difficilmente si abbronzava; e un altro ancora detto occhio bacchino. Solo io, e non avevo mai capito perché, non avevo un vero e proprio soprannome, ero (e sono) per tutti “Giannino”.
C’era un volto che, in assoluto, mi colpiva sugli altri, quello dolce del mio compagno del cuore: Salvatore De Luca che piaceva pure a mamma e a papà. C’era un motivo di quella preferenza. Salvatore viveva solo con la nonna che l’aveva cresciuto, dopo la morte prematura della madre, perché suo padre all’improvviso era emigrato in Germania senza dare più notizie di sé e dimenticandosi di avere un figlio. Al cuore di mia madre, quel bambino, così sfortunato rispetto a noi, era speciale e la nostra casa divenne la sua. Tutte le mattine Salvatore veniva a prendermi per andare a scuola. Ci concedevamo, prima delle fatiche poco amate, una colazione con latte caldo, caffè e buondì Motta, che mia madre preparava con cura per entrambi.
Dal capitolo X “La morte in faccia”. Scontro con la camorra.
Chi è nato a Napoli, purtroppo, non può ignorare la camorra, una piaga plurisecolare. A chi, poi, investe in un’attività in proprio o ha scelto di fare l’imprenditore, prima o poi, tocca doverla guardare in faccia. Importante, in queste circostanze, avere nervi saldi e schiena diritta, mettendo subito in chiaro, facendo capire che la camorra, se vuole provarci, con te va a sbattere contro un muro. La strada più breve per farlo percepire anche al più spietato dei boss è naturalmente la denuncia: con la denuncia si rompe ogni indugio che favorisce i ricattatori, salta la scorciatoia pericolosa della trattativa e del cedimento.
E la sfida diventa pubblica, dal momento che al tuo fianco scende in campo lo Stato, l’unico, vero e implacabile nemico dell’antistato. Io, fin da ragazzo, ho avuto modo di sentire parlare degli effetti distruttivi di questo cancro, che lentamente, alla distanza, macera le cellule sane, infettando il tessuto sociale. Mio padre mi raccontò di come all’improvviso questo triste fenomeno trasformò la Duchesca dei tempi lontani, di quando era piena di vita, di gente che vi operava in tutta sicurezza tra negozi e bancarelle, in un luogo di insidie.
Ne parlava e se ne rammaricava spesso la sera in famiglia, dicendo che si era passati da un mondo idilliaco alla giungla. Il volto della camorra, della minaccia calcolata e perseguita, quella che sfrutta la paura me la trovai davanti una mattina in carne e ossa. Mentre attraversavo il cortile della fabbrica, a un tratto mi sentii chiamare: «Voi siete Giannino, è vero?». Il mio nome, pronunziato e preceduto da quel “voi”, con quel tono del tutto inusuale, mi fece voltare subito in direzione della voce. «Chi siete?». gli chiesi, trattenendo un leggero impulso interiore. Quello mi tese la mano e, mio malgrado, istintivamente gliela strinsi. «Mi chiamo Ciruzzo, gli altri mi conoscono come ‘o curnutiello; vengo da S. Antimo e vi debbo parlare». «Sono qua. Ditemi cosa volete, ma sbrigatevi perché devo lavorare », risposi con piglio deciso, di cui quell’uomo si stupì. Avevo sentito che con questa gente, se non dimostri sicurezza, soccombi prima ancora di incominciare. «Appunto di lavoro vi volevo parlare.
Dovete assumere mio fratello », la richiesta, così cinicamente formulata, non ammetteva dinieghi. Tuttavia, non mi lasciai intimorire, gli dissi: «Questo mi dispiace, almeno per il momento, non credo sia possibile. Qui è già 98 tutto al completo, del resto siamo solo agli inizi dell’attività. Ma tra un po’ di tempo…». Ciruzzo mi piantò in volto due occhi rossi rabbiosi, di brace e replicò: «Allora ripasso fra quindici, venti giorni». Dopo quindici giorni si ripresentò ma gli risposi che, ancora una volta, non potevo accontentarlo; lui di tutta risposta, mi disse: «Allora vuol dire che, se non potete assumere mio fratello, dovete darmi in cambio cento milioni. Vi do due giorni di tempo per darmi una risposta. Dopodomani ci rivediamo». Mi sentii gelare ma, con la più decisa delle impassibilità, replicai a muso duro: «Cento milioni? Magari ce li avessi. È inutile che vi scomodiate a tornare tra due giorni, vi posso dire fin da ora che non ce li ho».
Avevo allora ventitré anni e due figli, ogni mia parola sottostava a un duplice senso di responsabilità: familiare e sociale, di etica privata e pubblica, coincidenti nel respingere ogni ricatto. Pensando che io cedessi, preso alla sprovvista, si limitò a dire: «Ah, nun ’e tenite?». E se ne andò. Dopo due ore, tornò nuovamente alla carica, non da solo ma con delle auto al seguito, accompagnato da un vero e proprio commando da esecuzione, come se fosse stato lui ad essere stato minacciato. Era l’ora della pausa pranzo e, come sempre, mia moglie si tratteneva senza sosta per andare via in orario utile a prendere i bambini all’uscita di scuola. Vide due macchine entrare nello stabilimento e, con un sesto senso che solo le donne riescono ad avere, intuì che qualcosa non andava. Non le avevo raccontato dell’incontro per non preoccuparla ma lei capì che c’era qualcosa di strano, ebbe una brutta sensazione, corse in ufficio da me, in fondo al corridoio e mi disse di non muovermi, di stare fermo nella stanza. I malviventi girarono i capannoni con le pistole spianate a spaventare gli operai, poi andarono via dicendo di avvisarmi. La “missione” andò a vuoto ma non mi facevo certo alcuna illusione sulla rinuncia da parte di quella banda a tornare di nuovo alla carica nel modo più vile. Naturalmente, feci la denuncia, spe99 rando che scattasse da subito un piano di protezione, ma passai una notte insonne, assalito da tanti pensieri. Più che per me, la scena di quel commando mi preoccupava per gli affetti più cari, mia moglie e i miei figli. La prima e predominante voglia fu di lasciare subito Napoli con tutta la famiglia, ma il senso di responsabilità prevalse. Il destino, la voglia di restare e di resistere presero il sopravvento.
Da quel momento decisi che avrei avuto un’assicurazione sulla vita a favore dei miei figli e di mia moglie. La settimana dopo, mentre non avevo ancora rimosso l’idea di cambiare aria, quel camorrista fu ucciso in un agguato. La morte di un uomo fa sempre tristezza, anche quando sai che ha compiuto atti così spregevoli; io non gioii per quella vita umana stroncata in maniera così violenta, ma da quel giorno devo confessare che ripresi a lavorare con più serenità. Quell’episodio di tentata estorsione, seguito dalla mia denuncia, spinse il capo della Squadra Mobile di allora, Franco Malvano, a interrogare tutti gli imprenditori della zona nell’ambito di un’operazione contro il triste fenomeno delle estorsioni, per contrastarlo con efficaci misure. Venne così a galla che molti di loro pagavano il cosiddetto “pizzo” pur di lavorare, quello che io avevo energicamente rifiutato di fare, denunziando senza pensarci su due volte l’episodio di malaffare. Malvano trattenne tutti in questura più di un giorno, a me invece disse: «Signor Lettieri, lei può andare via. Ho visto che ha già fatto una denunzia qualche tempo fa, come ogni buon cittadino dovrebbe fare. Le auguro buona giornata».
Dal capitolo XXII “La prossima corsa”. La maratona di New York
La prossima corsa è già dietro l’angolo. Non è un caso che ho scelto di correre. In tutti i sensi. Nella vita, nell’impresa, nella politica, nel tempo libero. Negli anni dell’adolescenza non c’era verso di fermare la mia corsa.
Non si corre mai tanto come dietro ai ricordi. Vorresti prenderli tutti, recuperare volti e cuori del tempo che fu. Vorresti ritrovare quel bel cappotto grigio, rigiocare quelle partite infinite, segnare di nuovo quei gol, rincontrare gli occhi di mia madre. Il passato non è mai passato. Eppure bisogna imparare a correre verso nuovi arrivi.
Uno dei migliori allenamenti per apprendere l’arte del futuro è correre davvero. Quel po’ di tempo libero che mi rimane è tutto dedicato alla famiglia e al senso della corsa. Scarpe, cronometro, sudore, mente sgombra, vento, solitudine, polmoni, strada, tanta strada. Io e me stesso: questo è correre. Una disciplina interiore, una metafora della vita, una sfida continua ai propri limiti, uno schietto faccia a faccia con quel grande avversario che alberga in ognuno di noi. Ho scelto la corsa, dopo aver praticato tanti sport (calcio, tennis, sci…), perché avevo sempre il rimorso di aver tolto del tempo ai miei cari; al contrario con la corsa posso allenarmi in orari improbabili, tipo le 6 del mattino, e sentirmi in pace con me stesso per non essermi privato di nulla. Bastano un paio di scarpette ed un pantaloncino ed ovunque mi trovo, in giro per il mondo, posso correre. Solo a Teheran non sono riuscito a farlo: il portiere dell’albergo mi fermò sconsigliandomi di recarmi per strada in pantaloncino, avrei rischiato di essere arrestato dai pasdaran.
La corsa è libertà, concentrazione e sacrificio; mi ha dato la possibilità di vedere panorami e paesaggi bellissimi. Mi piaceva molto correre a New York, al Central park, dove è facile incrociare attori di fama mondiale che amano tenersi in forma, gente disinibita che fa sport vestita in maniera improbabile, uomini e donne che fanno jogging spingendo altissimi passeggini. Il Central park è bellissimo soprattutto d’inverno, quando la neve imbianca tutto il paesaggio e incornicia il laghetto, che diventa un posto incantato. In queste occasioni penso sempre alla mia città e a quanto sarebbe bello che questo modello si potesse esportare e realizzare anche a Napoli. Ho sfidato prima di tutto me stesso quando mi sono preparato per la maratona di New York. Ho iniziato il 17 agosto e sono arrivato, nel mese di ottobre, a percorrere almeno 3 volte 32-35 km; sono stato fortunato perché in questi allenamenti avevo il sostegno di cari amici che mi seguivano in staffetta. In particolare uno, Paolo Ferretti, che purtroppo oggi non c’è più, mi aspettava a qualsiasi ora del mattino per accompagnarmi e si innervosiva molto con chiunque disturbasse la mia corsa in quel periodo.
Uno degli allenamenti, uno lungo di due ore, avvenne mentre mi trovavo per lavoro a Dubai, per incontrare dei produttori di cotone grezzo da acquistare. C’erano 40 gradi all’ombra ed era quindi impossibile correre all’aperto. Andai in una palestra enorme, la più bella e completa vista nella mia vita, che era gestita da ragazzi americani. Mi videro correre sul tapis roulant e dopo la prima ora si avvicinò una ragazza un po’ preoccupata che mi chiese come mai mi allenavo così duramente. Le spiegai che mi preparavo per la maratona di New York e dal quel momento in poi ebbi un’assistenza incredibile: mi portavano continuamente asciugamani freschi, acqua, integratori. Capii presto che per gli americani i partecipanti alla maratona sono degli eroi e ne ebbi conferma quando, a New York, alla fine della gara, mentre camminavo per strada con la medaglia al collo, notai che le persone mi guardavano con grande ammirazione. … Senza dubbio, però, l’esperienza più incredibile per un corridore è la maratona di New York. Arrivò anche per me il grande momento.
Partii da Napoli il giovedì e in aereo incontrai tanti napoletani che come me affrontavano quell’esperienza. Arrivò presto la domenica e già alle 5 del mattino un pulmino venne a prelevarci in albergo. L’aspetto più massacrante della maratona è l’attesa. Ci portarono ai piedi del Verrazzano Bridge, dove aspettammo l’inizio della gara fino alle 10.30. Nel frattempo ci offrirono da bere e da mangiare e continuamente un elicottero sorvolava lo spazio dove eravamo in attesa, vigilando sulla nostra incolumità e ripetendo in tutte le lingue che le forze armate americane proteggevano i partecipanti. Tutto ciò che avremmo abbandonato durante la corsa, veniva raccolto da associazioni che poi lo avrebbero dato in beneficenza. Prima che con le gambe la maratona si affronta con la testa. C’è bisogno di tanta concentrazione ed io trovai un escamotage per rimanere concentrato e darmi forza: ad ogni chilometro azzeravo il cronometro ed era come se ricominciassi ogni volta daccapo. Era la mia prima maratona e feci un errore di inesperienza: una partenza troppo veloce che ho pagato nelle ultime miglia. Trascinato dall’entusiasmo ho percorso il primo e il secondo miglio in 6 minuti e 40 secondi, in seguito mi sono attestato sul tempo di 7 minuti e 31 secondi, quello giusto per me.
Dopo i primi metri ebbi un grande spavento perché un crampo al polpaccio mi procurò forti dolori; verso la fine del percorso, invece, ebbi delle forti contrazioni al fegato, direi dei dolori, perché era finito il glicogeno per la veloce partenza in salita. In entrambi i casi temetti di dovermi fermare o addirittura di dover abbandonare la corsa. Mi vennero in mente i mesi di duro allenamento e i sacrifici. Anche in questo caso la determinazione mi aiutò: continuando a correre, ma ad un’andatura più lenta (per alcune miglia a 8 minuti e 30 secondi a miglio) il dolore al fegato diminuì fino a scomparire, e quindi potei riprendere la mia andatura, anche se questo inconveniente mi fece perdere un po’ di tempo. Appena finita la corsa e recuperato lo zainetto lessi il messaggio di mio figlio Geppy che mi aveva seguito per tutto il percorso dall’Italia sul pc grazie al cip che avevo sul piede, riuscendo a vedere, chilometro per chilometro, a che velocità stavo andando. Un’organizzazione straordinaria, questa delle maratone di New York, di Boston o di Londra, che mi piacerebbe molto portare a Napoli. Avevo concluso in 3 ore, 21 minuti e 56 secondi: quel 5 novembre del 2006, più che al tempo impiegato a percorrere i 42 chilometri e 195 metri, tenevo soprattutto a vivermi, fino al traguardo, tra i giganti di vetro della Grande Mela, l’esperienza straordinaria del correre. Il coraggio di partire, la voglia di crederci, la ricerca spasmodica del ritmo, la convinzione che l’addestramento non finisce mai, il sogno di un nuovo arrivo. È per questo che continuo ad allenarmi e che mi sento pronto per la prossima maratona.
Entra nel mondo del lavoro
Il mio ingresso nel mondo del lavoro e degli affari non avvenne come lo avevo immaginato; a volte, o meglio quasi sempre, i progetti della vita prendono una piega diversa, indipendente dalla nostra volontà. Avevo conseguito il diploma all’Istituito Tecnico Porzio, con un anno di anticipo rispetto al regolare corso scolastico e, in cima ai miei pensieri, ora c’era soltanto la laurea in Economia. Lo avevo promesso a me stesso, a miei genitori, a Maria, che l’avrei conseguita e lei mi stava aiutando nel programmare il piano di studi. Grazie a lei avevo compreso quanto fosse importante quella preparazione alla vita, lavorativa e non, che solo lo studio riesce a darti e, considerata la mia naturale propensione per il mondo degli affari, niente avrebbe saputo darmi le basi giuste, su cui poggiare tale vocazione, se non adeguati studi di Economia. E, ne ero certo, a differenza degli studi scolastici che mi avevano portato al diploma non senza difficoltà, nel mondo universitario mi sarei trovato perfettamente a mio agio e per la prima volta, forse, avrei sperimentato cosa significasse studiare davvero con curiosità e interesse.
Appena qualche mese prima, dunque, con tanti bei propositi condivisi con Maria, mi ero recato presso la segreteria dell’Università per l’iscrizione, dove mi diedero il libretto col numero di matricola, che guardavo e riguardavo con soddisfazione. Tutto pareva andare per il meglio quando una sera, rientrando a casa sul tardi, di ritorno dalla casa di Maria, la vita mi pose di fronte a una scelta obbligata. La luce accesa in cucina ad un’ora insolita della notte, mio padre ad attendermi: intuii che qualcosa non andava. Mi guardò e dalle poche contenute parole che mi disse sul suo stato di salute, capii molto bene che non poteva affaticarsi oltre. Il medico infatti gli aveva prescritto un piano di cure e il riposo assoluto. Questo significava che sarebbe dovuto restare fermo a lungo: un supplizio per una persona dinamica come lui. Da tempo aveva iniziato a commercializzare indumenti militari e aveva contatti con un’azienda di La Spezia, di cui aveva preso una partecipazione insieme ad altri soci, indebitandosi fino al collo. Voleva fare qualcosa di diverso, di più importante.
Avevano vinto solo da pochi mesi una grossa fornitura, partecipando con successo a un’importante asta pubblica. A parte la mole di lavoro che occorreva governare, a preoccuparlo erano l’affidabilità dei soci e di chi avrebbe potuto gestire l’impresa in maniera produttiva, cercando di non penalizzare l’azienda. Mentre lo accompagnavo verso la camera da letto dove mia madre già dormiva, come si fa con un bambino che ha bisogno di essere rassicurato, mi accorsi che si rammaricava del “riposo obbligato”, per il fatto che mi ero iscritto all’Università, che sarebbero iniziati i corsi a cui io tenevo molto, che avevano destato tanto entusiasmo nelle settimane precedenti e che, dovendolo aiutare, avrebbe suo malgrado compromesso le mie aspirazioni, di cui andava orgoglioso. Io capii, cercai di rassicurarlo sulla provvisorietà di quella situazione, cercavo di convincerlo che sarebbe stato presto meglio ed avrebbe ripreso in mano tutto, e terminai dicendogli: «Papà, stai tranquillo. Il tuo posto, per ora, lo prendo io». Tornando nella mia stanza quella sera non riuscivo ad addormentarmi, passai tutta la notte a fissare il soffitto. Avrei voluto chiamare Maria per condividere quell’angoscioso momento, per avere una parola di conforto, ma era troppo tardi; aprii il cassetto del comodino, presi il libretto universitario e cercai di convincermi che quel percorso di studio era solo rimandato, che si trattava di una situazione transitoria, che mio padre si sarebbe ripreso alla grande e che tutto sarebbe tornato al punto in cui si stava bruscamente interrompendo.
Il lavoro negli ultimi tempi era stato gravoso e sicuramente mio padre ne aveva risentito. Per me gli inizi, la spola tra Napoli e La Spezia, furono pesanti e non certo felici, anzi, mi crearono molti problemi. Oltretutto avevo fatto un salto improvviso al vertice di un’azienda ancora in rodaggio, era normale il mio iniziale disorientamento. Il convincimento, sempre più avvertito, che solo attraverso le difficoltà generate da esperienze nuove si possono raggiungere mete rilevanti, fu decisivo nel farmi guardare avanti con fiducia. Tanto più valeva per uno come me che non voleva accontentarsi di fare il commerciante, di seguire, insomma, un percorso predeterminato, ma aveva in mente una sola prospettiva: costruire qualcosa di importante. La Spezia significò una sorta di leva militare, vi risiedevo dalla domenica al giovedì per seguire di persona l’azienda. Furono due anni preziosi che mi insegnarono tanto: a tenere in piedi e solida un’altra grande sfida, e a stanare l’azione truffaldina di un socio infedele che agiva da tempo come un insidioso parassita. Ecco cosa successe. Nel verificare le procedure obbligate dell’impresa, al momento di pagare i contributi, mi insospettì una strana consuetudine: mio padre aveva sempre mandato quel socio alla Posta a pagare i bollettini contributivi, mentre per sé riservava il pagamento delle cambiali. Abituato all’operatività, un giorno lo seguii di nascosto all’ufficio postale. Non fui abbastanza attento, però, e il socio si accorse di essere spiato quando era già appostato davanti allo sportello. Cercando di depistarmi, versò l’intera somma di 8 milioni e 330mila lire. Di fronte a quella scena, verificando di persona la correttezza dell’operazione, mi sarei dovuto ricredere.
Qualcosa però ancora non mi convinceva. A darmi conferma dei sospetti, pochi giorni dopo, fu un’ispezione dell’INPS: ben quindici ispettori a La Spezia restarono per ore a controllare i registri e i bilanci. Ciò mi spinse, la mattina dopo, a presentarmi personalmente negli uffici dell’INPS, portando con me, a riprova che tutto era in regola, i bollettini pagati mese per mese. Così mi capitò di scoprire l’incredibile: le cifre pagate erano di gran lunga inferiori ai contributi che figuravano nella contabilità della società. Il truffatore, invece di 8 milioni e 330mila lire, pagava solo le 330mila e poi a penna aggiungeva sulla parte del bollettino di conto corrente che restava in azienda l’8 davanti alla cifra; il gioco gli aveva talmente preso la mano che pagava solo le 30mila finali, aggiungendo ben due cifre. I bollettini erano falsi, contraffatti. Perfino quello che io avevo visto pagare. Anche il giorno in cui lo avevo seguito, dopo che me ne ero andato, lui facendo finta di essersi sbagliato aveva pregato il direttore dell’ufficio postale di fargli annullare il bollettino e lo aveva riscritto, pagando di nuovo una cifra nettamente inferiore. La rabbia fu tale che ebbi una gran voglia di picchiarlo; lo attesi per un giorno e una notte sotto casa ma, fortunatamente, qualcuno lo aveva avvertito, evitando il peggio. Non mancarono altre avventure, o disavventure, che ebbero per me l’effetto di accelerare una scelta, già da tempo maturata: mettermi in proprio, come già avevo fatto con qualche precedente esperienza. Stavolta fui io a rischiare, pur di lavorare.
